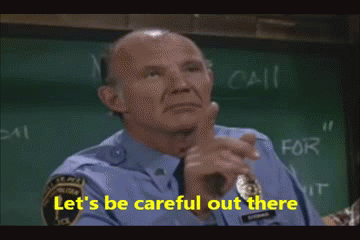Quello di sopravvivere alla propria dipartita è un sogno condiviso da molti. L’idea di rimanere – nel bene e nel male– per un certo periodo di tempo nella memoria di qualcuno è certamente una lusinga, quando si è ancora in vita. Ma che ciò si verifichi poi effettivamente – e magari su vasta scala – per i più è soltanto una segreta speranza. Solo pochissimi possono dire, in vita, di avere questa certezza.
D’altra parte non è detto che l’essere ricordati una volta che si è “varcata la soglia” sia qualcosa di necessariamente positivo.
Nel film “Mortacci” di Sergio Citti le anime dei defunti si intrattenevano in un cimitero in cui erano “allegramente confinate” fino al momento in cui nel mondo dei vivi tutti si fossero dimenticati di loro.
Una attesa che può comprensibilmente diventare snervante per chi, in vita, avesse fatto tanto bene (o anche tanto male) da essere ricordato a lungo. In ogni caso un problema questo che – a prescindere dalle motivazioni che lo avevano generato – i personaggi del film ambivano di risolvere al più presto, augurandosi un rapido oblio nella terra dei vivi (e ringraziando di non essere nati al tempo di Google…).
In effetti il film è del 1989 quindi l’unica memoria cui gli sceneggiatori potevano ragionevolmente riferirsi era quella di tipo organico, biologico, quella memoria cioè a cui accediamo “senza strumenti” e che perdiamo irrimediabilmente con il passare degli anni (fino al punto in cui finalmente dimenticheremo anche di aver perso la memoria), quella memoria che all’epoca poteva ricevere qualche aiutino solo dalla mera documentalità cartacea o – nel migliore dei casi – da quella magnetica che aveva appena smesso di essere floscia proprio in quegli anni.
Nel 1989 non c’erano (forse…) i big data, non c’erano i “social network” (ma – e non è una battuta – le reti sociali si), certamente non c’erano Facebook, Linkedin. Twitter e i loro cugini più o meno famosi. Si sarebbe potuto girare Mortacci al giorno d’oggi? Quale potrebbe essere il suo messaggio oggi che sentiamo parlare continuamente di crescita “esponenziale” (?) dell’informazione, oggi che si discute (giustamente) di diritto all’oblio su internet?
Quanto tempo dovrebbe aspettare oggi una povera anima – che in vita abbia avuto relazioni sociali, affettive, lavorative, accademiche diciamo così “standard” – per poter ambire all’oblio, quindi alla sua libertà?
Non abbiamo idea di come Giulio Andreotti la pensasse riguardo a questi argomenti. Tuttavia possiamo forse intuire che non ci tenesse poi così tanto al dimenticare – e nemmeno, a dirla tutta, ad essere dimenticato… – se, come ci racconta Barbara Carfagna nella puntata numero 33 di “Infosfera”, nel corso della sua vita il Senatore è riuscito a costruire un “archivio personale” che oggi si estende in un sotterraneo per l’equivalente di ben 600 metri lineari.
Un archivio talmente significativo da trasformarsi esso stesso in motivazione mnestica: Andreotti oltre che attraverso il suo archivio sarà ricordato per il suo archivio. La differenza è sottile ma significativa.
Più volte, chiacchierando di intelligence delle fonti aperte, abbiamo richiamato (in questa e in altre sedi) l’attenzione sull’importanza che per l’intelligence e gli studi di intelligence rivestono – o dovrebbero rivestire – concetti come informazione, infosfera, inforg e “documentalità“.
L’esempio dell’Archivio Andreotti è emblematico. Un “archivio” non è un semplice “accumulo documentale”. Lo scopo primario di un archivio è senza dubbio la “conservazione”; ma un archivio è soprattutto rappresentatività, coerenza (non può esserci un archivio di “certe cose” ma un archivio di “quelle specifiche cose”). Un archivio è “struttura”, organizzazione, categorizzazione, indicizzzione. Se vogliamo un “archivio” è anche una fonte di informazioni sulle informazioni che contiene e che in qualche modo, appunto, descrive.
Le attuali tecnologie dell’informazione moltiplicano le “inscrizioni” da parte dei loro utenti: probabilmente il 95% di coloro che hanno un account su un social network non ha mai scritto tanto (informando sulla propria vita, sulle proprie attività, sui propri affetti, sui propri pensieri e suoi propri… gatti) come da quando esiste facebook.
Probabilmente in tutto il periodo della sua istruzione primaria e secondaria un individuo non scrive tanto quanto scriverà da adulto su Facebook (probabilmente su Facebook scriverà qualcosa di sicuramente peggiore, ma non è questo il punto in discussione in questa sede). Probabilmente nessuno di noi si è impegnato tanto a descrivere analiticamente e aggiornale il proprio profilo professionale (anche se fa il cameriere in una pizzeria) come da quando esiste Linkedin.
Tutto ciò fa esplodere la documentalità (o meglio la proiezione documentale delle nostre esistenze) e con essa tutti i suoi vantaggi e svantaggi (morendo saremo tutti ricordati all’infinito da un sistema info-mnestico universale che si chiamerà GodBook?).
In realtà è tutto perfettamente normale per degli organismi informativi (inforg) quali siamo, immersi come siamo in un ambiente – l’infosfera – dove oggetti, informazioni e relazioni si intrecciano in una pluralità di reti il cui scopo ultimo è backupparae informazioni.
Ma ciò a cui volevo arrivare è un esercizio di immaginazione basato sull’ esempio dell’Archivio Andreotti. E’ fin troppo chiaro che questa “capacità documentale” fino a qualche tempo fa era così onerosa che potevano permettersela solo in pochi.
Immaginiamo invece come sarebbe un mondo (o il nostro Paese, o la nostra città, il nostro quartiere oppure anche solo – ancor meglio – il nostro condominio) se tutti fossero obbligati per legge a costruire e accrescere il proprio archivio personale così come ha potuto fare Andreotti.
Certo non tutti hanno la vita sociale di un famoso politico (o di un famoso artista, un grande accademico, eccetera) pertanto l’estensione dell’archivio non arriverebbe certo ai 600 metri lineari dell’archivio del Senatore a vita. Ipotizziamo perciò arbitrariamente che l’archivio di un “comune mortale” (chi vi scrive, ad esempio) si assesti in media sui 50 metri e proviamo a fare due conti.
La mia famiglia è composta da tre persone adulte: 50 metri per 3 persone fanno 150 metri lineari. Il pianerottolo di casa mia serve due appartamenti, il mio e quello del dirimpettaio. Ipotizzando che anche la sua famiglia sia composta di tre persone arriviamo a 300 metri lineari di archivio solo per il mio piano.
Il palazzo in cui abito conta tre piani (3 piani x 300 metri = 900 metri lineari di archivio) più un livello strada adibito a uffici (facciamo 100 metri lineari di archivio): 900 metri +100 metri sommano 1000 metri lineari di archivio: un chilometro di archivio solo per il mio palazzo.
Ma proseguiamo. Nel mio isolato ci sono tre palazzi dalle dimensioni paragonabili al mio. Mantenendo tutte le medie adoperate fino ad ora in totale il mio isolato produce più o meno 3000 metri lineari di archivio. Tre chilometri di carte e di strada, se messe in fila. Ciò vuol dire che – a piedi e a una velocità media di 3 Km l’ora – se volessi accedere al primo e all’ultimo documento di questo “archivio dell’isolato” impiegherei un’ora solo di viaggio.
Ci siamo fermati all’isolato ma… andiamo ancora avanti. Se, anche senza allontanarci troppo dal portone di casa nostra, ci guardiamo intorno ci accorgeremmo, ad esempio, degli archivi delle altre aziende del circondario, magari di quelli del presidio della ASL, quelli della scuola elementare che frequenta nostro figlio, quelli della biblioteca comunale della quale abbiamo la tessera in tasca. E poi ancora quelli (chiusi con la sbarra e il lucchetto a combinazione) della locale caserma dei Carabinieri e alla via così.
Siamo davvero certi che l’esplosione delle informazioni sia un fenomeno recente?
Pensiamo ora al nostro posto di lavoro, quello vero intendo, nel mondo reale.
Che siamo imprenditori, liberi professionisti, cardiochirurghi o dipendenti pubblici siamo consapevoli dell’ingombro – in termini di “spazio digitale”- del corpus documentale che produciamo: se siamo seduti davanti al PC dell’ufficio possiamo sostenere “al massimo 500GB”, che è la capienza massima del disco fisso. Se siamo imprenditori e lavoriamo col tablet possiamo sostenere “al massimo 64GB” che è la capienza massima del nostro iPAD (cloud a parte, of course…). Se siamo fotografi di matrimonio sappiamo che per una cerimonia completa ci occorrono almeno 4 schede SD da 32GB.
Ma sappiamo stimare con la stessa precisione e la stessa immediatezza a quanti metri lineari equivale il nostro archivio cartaceo? Probabilmente ci stupiremmo di quanto sia facile ritrovarci con un risultato largamente sottostimato.
La verità è che la “società dell’informazione” (e di conseguenza le espressioni documentali della società) non è un concetto nuovo, proprio per niente. L’abbiamo semplicemente trasformato nei secoli fino al punto in cui – in tempi recenti – ci è piaciuto caricarlo di un significato magico, inarrivabile, inemendabile: l’immagine terrificante di un mondo in cui i dati e le informazioni si riproducono vertiginosamente brulicando tutto intorno e consumando ogni molecola di ossigeno disponibile, condannandoci ad una morte lenta e disperata (ma con il vantaggio di essere ricordati all’infinito però!).
L’atto conclusivo di un’opera drammatica che potrebbe intitolarsi “il suicidio degli organismi informativi umani”.
Il guaio è che – sembra – siamo bravissimi a parlare e straparlare (e questo post ne è la dimostrazione in termini) di esplosione delle informazioni, di data-driven innovation (o revolution, a seconda dei casi), di Big Data come arma digitale contro il terrorismo o come strumento per “…decriptare la realtà per quella che è” (e perché la realtà dovrebbe essere “criptata”?)
Ma più che parlarne e istituire qualche Commissione o Agenzia (in modo che se ne possa parlare… di più) non siamo capaci di fare.
Il “mondo là fuori” è ancora pieno di informazioni che devono ancora entrare nel dominio digitale: un patrimonio informativo che – a poterci accedere in modo organico – nasconde un vero e proprio tesoro. Ed è anche in questo che risiede la mia critica storica – espressa anche nel mio Open Source Intelligence Abstraction Layer – alla visione attuale di OSINT come una mera “intelligence di internet” o – ancor peggio – una intelligence fatta con i motori di ricerca, una “googl-int” insomma.
La riduzione dei concetti di disponibilità e accessibilità dell’informazione al solo “dominio digitale” (ovvero il prendere in considerazione solo fonti e informazioni che sono su internet) che ormai sempre più frequentemente si osserva in OSINT (basta googlare – appunto – e leggere i programmi delle iniziative di formazione nel settore dell’open source intelligence) mortifica la disciplina (in termini qualitativi, quantitativi e strategici) e il concetto stesso di “informazione”.
Perciò il “consiglio agli analisti” di oggi è: spegniamo il computer per “vedere” le informazioni che abbiamo intorno. Accendiamolo per analizzarle, condividerle e scambiarci pareri. In ogni caso non fa alcuna differenza se abbiamo il computer acceso o spento: “là fuori” c’è sempre e comunque l’infosfera.
Andreotti l’aveva intuito?